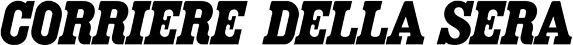Vivere & scrivere
di Marco Celati - Domenica 09 Ottobre 2016 ore 17:00

Non ho mai vissuto la vita, se non scrivendola, lo diceva nientemeno che Luigi Pirandello. E può darsi che sia vero. Nel mio piccolo ho scritto e pubblicato in rete "Ferragosto a Quercianella" e mi sono tornati in mente episodi che non ricordavo più. Ho rievocato un'altra vita, un altro me stesso, diverso e lontano dall'uomo che sono diventato. Come se il passato e la gioventù appartenessero ormai ad un'esistenza che non importava più ricordare di aver vissuto. Una memoria scaricata in remoto di una vita e di un mondo non più consultati o consultabili. Dimenticati. Quasi non fossero mai esistiti. Scrivendo li ho riportati in vita. Non solo, ma alcuni amici di allora, che hanno letto il racconto, mi hanno contattato. Veramente non l'avrebbero mai letto se non gliel'avessi inviato. Questa è una delle differenze fra me e Pirandello. Comunque l'hanno letto, ci siamo sentiti ed è stata proposta e organizzata una "rimpatriata". Ci siamo trovati insieme dopo tanti anni e siamo tornati a Quercianella, nella Cala dei Frati, il luogo prediletto delle nostre estati.
Io non c'ero più stato da allora. La nostra Cala era ancora bellissima, poco frequentata, preservata dall'invasione di turisti e villeggianti. Come la ricordavamo. Gli scogli delle Pecorelle indirizzavano verso il largo, solo smussati dagli anni e dalla forza dei marosi. Lo Scoglino e lo Scoglione erano al loro posto. Ogni cosa era riconoscibile. L'acqua chiara e pulita. A riva legni levigati e schiariti dal mare, ammassati dalle bufere, mostravano l'arte e la forza della natura. Il muro dispensatore di calore, che ci asciugava dopo i nostri bagni al tramonto, era sempre lì e sembrava averci atteso. Solo una parte della scalinata che metteva alla Cala era crollata e un cartello ammoniva del pericolo i bagnanti. Il tempo mai invano trascorre per gli uomini e il mondo, eppure mi è parso che quel luogo ritrovato conservasse anche un po' di quello che siamo stati e di come eravamo. Le grida, i silenzi, i tuffi nell'acqua e nel cuore, le aspettative e le sconfitte che si annunciavano allora e che avremmo vissuto. Abbiamo passato il resto della giornata a rievocare quella piccola e significativa parte delle nostre vite. Giovanni, l'amico di gioventù, aveva portato vecchie foto di scuola ed altre, in bianco e nero, i colori del secolo scorso. Così sono riaffiorate alla memoria anche altre cose del nostro vissuto.
Avevamo tredici anni, forse. Con Giovanni ed un altro amico, Riccardo, andammo in montagna in Val d'Aosta. Andammo con Don Mario, il prete rosso, rosso di capelli, e la sua cinquecento. Il Don guidava bene, come si può guidare una cinquecento del tempo, in quattro a bordo, su per le salite valdostane. Solo non sopportava quando altri piloti, più abituati ai tornanti alpini, lo sorpassavano in maniera un po' avventata e a qualcuno, più imprudente degli altri, impartiva la sua santa e celeste benedizione, apostrofandolo con un toscanissimo "pe'oro!", gridato a finestrino aperto e a scanso di equivoci. Ridevamo complici, ma Giovanni lo riprendeva, richiamandolo alla più sobria compostezza dell'abito talare. A me venne un enorme foruncolo dietro la schiena che mi fece star male per una parte del viaggio. Dormivamo nelle tende canadesi e non riuscivo a riposare bene. Me lo fece scoppiare il dottore con un cucchiaio, solo ritornato a casa. Avevamo pochi soldi, quelli che si possono dare a dei tredicenni, e ricordo che avevo visto un piccolo calice in una mostra che visitammo, sulle terre di missione. Volevo comprarlo per regalarlo alla mamma, ma non fu possibile o non avevo i soldi sufficienti. Me ne crucciavo di continuo sulla via del ritorno, stremando i compagni di viaggio. Riccardo mi prendeva in giro. «Guarda» diceva, mentre l'auto correva «è passata una bottega con un'insegna: "Alimentari e Calici". Peccato, ce la siamo persa!».
Una sera ci accampammo in uno spiazzo erboso. Venne il contadino che ci disse che "il fero", l'auto, non poteva stare. Ci parlò Don Mario, fu un confronto di dialetti e giaculatorie. Restammo, ma l'indomani ce ne saremmo dovuti andare. Come infatti era già nostra intenzione.
Io sono curvo di mio: "cammina diritto", mi hanno sempre detto tutti, da mia madre in giù. Il foruncolo poi accentuava la postura. Così mi aggiravo intorno alla tenda guardando in terra, più del solito. E nell'erba trovai cinquecento lire d'argento, che al tempo erano una cifra. La provvidenza, commentò Don Mario! Che culo dissero gli altri, scusandosi con il sacerdote. Che fortunata coincidenza pensai io e, non so dove, comprai un souvenir, simile a quel calice che avevo visto, che portai con orgoglio a mia madre. Ho sempre pensato che Don Mario avesse buttato lui quei soldi per farmeli trovare, confidando nel mio incedere gobbo e supplendo così alla divina provvidenza che avrà avuto ben altre cose a cui provvedere. Era un bravo sacerdote, buono, timido e impulsivo e faceva simpatia. Quando lo trasferirono andammo tutti a salutarlo nella sua nuova parrocchia. Non ricordo altro di quel viaggio. Una foto che ci ritrae, e mi ritrae curvo, conservata da Giovanni lo ha riportato alla memoria. Mi resta come una sensazione di avventura, un senso di amicizia, un'eco di pomeriggi all'Oratorio dove in tanti siamo cresciuti per andare a nostro modo nel mondo.
A sedici anni, nell'estate del 1966, Giovanni ed io facemmo l'impresa. Avevamo programmato un viaggio, "low cost", si direbbe adesso. Quindici giorni, viaggiando in autostop e facendo tappa negli Ostelli della Gioventù. Giovanni soprattutto, che aveva la mappa degli Ostelli, aveva ideato tutto. L'itinerario era stato studiato e fu rispettato. Partimmo, zaini in spalla, che ancora faceva notte, approfittando del passaggio di un camionista che conoscevamo, che ci portò a Bologna. Da lì, chiedendo passaggi agli automobilisti, con il braccio teso e il pollice rivolto all'insù, facemmo tappa a Venezia. L'Ostello era sull'Isola della Giudecca, di là dal Canal Grande, davanti a Piazza San Marco. Venezia, Murano, la laguna erano un incanto. Poi, sempre in autostop, salimmo verso le Dolomiti, sul lago di Misurina, dove si specchiano le tre Cime del Lavaredo e il monte Cristallo. Ci arrivammo a sera e non sapevamo dove andare a dormire. Cominciava a far scuro, ci inerpicammo su un sentiero che saliva in montagna. Si intravedevano le luci fioche di una malga. All'interno un gruppo di pastori era raccolto in un androne. Mi pare che fossero intenti alla produzione del formaggio. Chiedemmo ospitalità. Ci accolsero nel fienile dove passammo la notte. Dormimmo sul fieno e ci coprimmo anche con la paglia perché si era d'estate, ma faceva un bel fresco. Al mattino partimmo per Campitello di Fassa, nel Trentino. Alloggiammo nell'Ostello, dove mi ammalai perché, come diceva la mia nonna, sono sempre stato un "impiastro senapato". Mi venne la febbre alta. Giovanni chiamò il dottore. Presi le medicine prescritte e qualche brodo caldo. Nell'Ostello c'era l'uso della cucina. Presto mi rimisi in salute. Ma la mia memoria confonde un po' le cose, sono un uomo da racconti brevi. Giovanni invece si ricorda che andammo a Canazei che si raggiungeva a piedi da Campitello, sulla riva sinistra di un torrente e facemmo un giro dei passi dolomitici, il Falsarego, il Pordoi. Visitammo Cortina. Puntammo su Riva del Garda dove entrammo trionfalmente, grazie al passaggio ricevuto da un riccone con un macchinone americano. E infine facemmo tappa a Milano.
Era previsto di espatriare in Svizzera e così facemmo o provammo a fare. Ma agli svizzeri l'autostop non doveva essere troppo gradito. I passaggi furono scarsi, facemmo poca strada, solo fino a Lugano, Lugano bella. Fu l'unica volta che dovemmo tornare indietro, cacciati come gli anarchici. E ci toccò prendere un treno. I treni magari erano puntuali come orologi: svizzeri per l'appunto. "Po' po' di stronzi!" O, come avrebbe detto Don Mario, se Giovanni gliel'avesse permesso, "pe'ori!" Le tappe successive le ricordo poco. Tornammo giù in Liguria e fummo a Lerici, mi pare. Poi rientrammo in Toscana e facemmo ritorno a Pontedera, a casa. Ricordo che, con i vestiti un po' malmessi e gli enormi zaini militari, camminavamo, verso le nostre abitazioni, lungo il viale della Piaggio. Era di sera e il viale scarsamente illuminato. Davanti a noi c'era un signore che, avendoci visto e sentendoci arrivare, allungava visibilmente il passo. Quel signore era un caro amico di famiglia: poi me lo disse che ci aveva preso per dei malintenzionati. Che viaggio! Il più coraggioso e avventuroso per quei tempi e forse per sempre nelle nostre vite. Almeno nella mia. Erano altri tempi. Sono passati cinquant'anni, mezzo secolo. Ormai quasi più nessuno chiede un passaggio. Tutti abbiamo più di una macchina in famiglia. Allora ci mettevamo sulla strada provinciale con l'asciugamano e, facendo l'autostop, andavamo al mare, a Marina, e tornavamo. E pensare che oggi, quando passo con l'auto e vedo un autostoppista, non mi fermo nemmeno: sono diventato diffidente, svizzero e forse stronzo e pe'oro pure io.
La giornata con gli amici di Quercianella, Giovanni, suo fratello Marco, è scorsa serena. Non era facile o scontato, dopo tanti anni, almeno per la mia introversa ritrosia, ma così è stato. Abbiamo fatto il giro di Quercianella e rivisto i luoghi dove loro mettevano la tenda, ospitandomi, d'estate. Il percorso che facevamo per andare al mare, il bar, la latteria. Marco, un po' più grande di Giovanni, aveva mantenuto i rapporti con quel luogo di gioventù. Almeno una volta l'anno era stato alla Cala per un bagno, una nuotata. Abbiamo ricordato quando la sera metteva i palamiti con un amico che aveva la barca e i filaccioni a nuoto da solo e poi il pesce pescato se lo vendeva. Era anche bravo nella pesca subacquea: lui, noi no. Marco è divenuto un ingegnere, un imprenditore che ancora s'ingegna, ha inventiva. La moglie è una professoressa che ha insegnato nelle nostre scuole. Sono nonni. Giovanni era un medico importante all'ospedale di Cremona, sua moglie ha una bella azienda agricola con mucche da latte. Ora è in pensione. Lui è un chirurgo, un urologo e io, in compenso, un prostatico ipertrofico. A pensarci bene lui è la cura e io la malattia: a volte quando si dice l'amicizia! Ci siamo scambiati le foto dei figli. Hanno avuto vite e affetti solidi, i miei amici.
Poi velocemente si è fatto sera. È arrivata l'ora dei saluti, degli abbracci, dei baci. Rivediamoci ancora, non perdiamoci di vista. Dobbiamo ritornare alla Cala, anche con Paolo, il fratello maggiore, assente giustificato.
I ricordi hanno richiamato le parole. Le parole hanno ridestato la vita che è stata e che andava ricordata. Ed è stato bello farlo. Questo racconto un po' la ricorda. E dunque: vivere o scrivere? Forse entrambe le cose: vivere e scrivere. Bisognerebbe amare le parole, come la vita e la vita, come le parole.
Pontedera, 3 Ottobre 2016
Marco Celati